di Antonino d’Esposito
Quanto possono ingannare i nomi poetici che diamo a luoghi che si trasformano in inferno? A sentirlo, il nome di uno dei tanti campi profughi palestinesi di Beirut, agli inizi della guerra civile libanese, pare una ventata di brezza estiva. Tel al-Zaatar, la collina del timo. Un fruscio evocativo che richiama alla memoria di chi abita le sponde del Mediterraneo la calura estiva impregnata del forte odore delle erbe spontanee. La realtà fu, però, tutt’altro che profumata.
L’assedio e il massacro seguito al crollo militare del campo, avvenuto il 12 agosto 1976, si inserisce naturalmente nel contesto della guerra civile libanese, iniziata un anno prima e preparata da una forte campagna d’odio nei confronti dei profughi palestinesi che erano arrivati nel paese a seguito dei vari conflitti tra mondo arabo e Israele. L’uccisione di ventisette persone, che dal campo di Sabra si stavano recando proprio a Tel al-Zaatar, fu una delle scintille che appiccò il fuoco alla brace latente della guerra. Nel corso del conflitto, uno degli obiettivi principali del partito falangista fu quello di “ripulire” le zone cristiane di Beirut sotto il proprio controllo dalla presenza di elementi non cristiani, che in questo contesto deve leggersi come “palestinesi”. Toccò prima al campo di Dbayeh, nella zona di Jounieh, poi al quartiere di Karantina e infine, nel gennaio del ’76, iniziò l’attacco a Tel al-Zaatar.
Questo episodio, uno dei momenti più cruenti della guerra civile libanese, si è inserito anche nella storia della letteratura palestinese contemporanea grazie a due autori imprescindibili di quella generazione: Mahmud Darwish e Liana Badr. Il primo, come ovvio che sia, ha rievocato la vicenda in un componimento, Ahmad al-Zaatar, pubblicato nel 1977 nella raccolta A‘rās (Nozze) e cantato poi da Khaled el-Habre (Qui il testo i arabo e la recita con la voce del poeta). Liana Badr, invece, col suo romanzo ‘Ain al-mir’ah, L’occhio dello specchio (MReditori, 2022, trad. di Antonino d’Esposito), compie un’operazione di salvaguardia della memoria collettiva attraverso l’uso della scrittura.
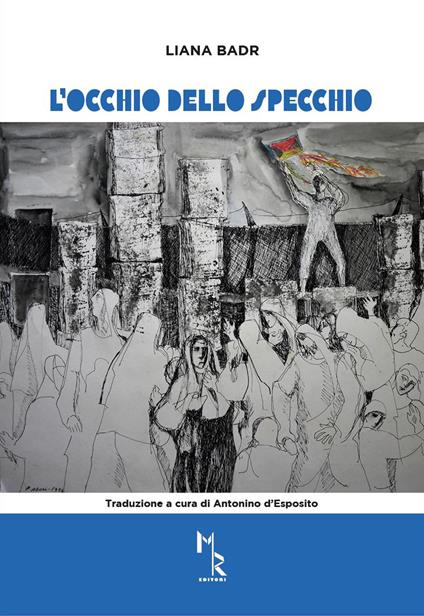
L’autrice (Gerusalemme, 1950) è sicuramente una delle voci più poliedriche e influenti delle lettere palestinesi del secondo Novecento. Scrittrice, poetessa e regista, nasce a Gerusalemme e cresce a Gerico, città che fa da sfondo al romanzo Le stelle di Gerico (Edizioni Lavoro, 2009, trad. G. Della Gala e P. Viviani) e che dovrà lasciare nel 1967 per trasferirsi in Giordania. A seguito degli eventi del cosiddetto settembre nero del ’70, troverà rifugio a Beirut dove, però, assisterà a tutto il cruento dramma della guerra civile libanese. A seguito degli accordi di Oslo del 1993 riesce finalmente a tornare in Palestina e si stabilisce a Ramallah, città nella quale ancora vive.
L’occhio dello specchio nasce da un lavoro di interviste che la Badr porta avanti con i sopravvissuti al massacro finale di Tel al-Zaatar; una raccolta di memorie, private e collettive, che nella penna della scrittrice si trasformano in un testo crudo e poetico. L’introduzione sognante sembra quasi nata dalla voglia di dare a quanto segue un manto di irrealtà. In una finzione letteraria, in cui la voce narrante pare vestire i panni di Shahrazad, l’io onnisciente esaudisce la volontà dell’amato che vuole sentire una storia; ma non una storia qualunque, proprio quella storia lì. Allora, quasi a mo’ di scuse, l’ineluttabilità di dover partire da Tel al-Zaatar si erge come imprescindibile punto di partenza al seguito.
L’uccisione delle ventisette persone citata poc’anzi si presenta subito all’inizio del romanzo nelle parole di Umm Jalal, la madre di Aisha, la protagonista, come una nenia ripetuta a più riprese che può solo far presagire future tragedie:
“L’autobus” e nel frattempo si nascondeva il volto come qualcuno colpito in fronte da un sole ardente e, con la punta della lingua screpolata, si nettava le labbra ovali; ansimava e muoveva le dita della mano sinistra sul petto come se stesse scuotendo via della polvere immaginaria dall’ampio vestito.
“L’autobus. Guai a me. Guarda che catastrofe, che sfortuna! Che hanno fatto che giovani e quei ragazzi per essere uccisi? Venti, mio caro, venti! Così ha detto tuo padre. Sono piombati su di loro, pum, pum!”
E poco oltre:
“Siamo diventati dei senzatetto. Non abbiamo patria, dignità, una casa. L’onore è perso da tempo, e ora i nostri figli muoiono. L’autobus, l’autobus, l’autobus! Che sfortuna nera!”
Proprio le donne e le loro parole, dette o taciute, sono il motore portante della narrazione. Gli uomini, anche quelli impegnati nella difesa armata del campo, sembrano portare un fardello meno pesante. Molto spesso relegata a capi famiglia inetti o vecchi, la figura maschile esce dal romanzo acciaccata e ridimensionata, mentre quella femminile si fa carico di tutto: delle sofferenze, delle difficoltà della vita sotto assedio, della cura degli altri e pure della lotta, anche se non armata. Proverbiali sono gli scambi di improperi attraverso i segnali radio tra i falangisti e Hana’, una delle forti donne dipinte da Liana Badr.
Chi più di tutte però impegna le pagine del romanzo è Aisha, non a caso forse l’autrice sceglie un nome che significa colei che vive, una ragazzina a malapena adolescente, strappata dal convento dove studiava e lavorava (pur essendo musulmana), a causa dell’evento del bus, e travolta, suo malgrado, sia dalle vicende belliche che dai soprusi di una società machista e maschilista. Lo choc del repentino ritorno a una normalità cui si sente aliena, un padre dai contorni foschi, un’infatuazione adolescenziale tradita e un matrimonio imposto metteranno a soqquadro la vita di Aisha, mentre il mondo fuori dalla baracca in cui viveva soccombeva alle bombe dei falangisti.
La scrittura mirabile della Badr, che spesso si scioglie in una prosa quasi poetica, non contrasta con la difficile realtà raccontata. Anzi, le due cose, antitetiche da un certo punto di vista, si uniscono per dare maggiore forza allo scopo che sottende al testo: fornire una testimonianza di prima mano della tragedia. Così, prendendoci per mano, Liana Badr, da regista quale è, ci fa scorrere davanti le parole-immagini di un evento ignominioso che tutti, la comunità internazionale, quella araba, l’opinione pubblica libanese, restarono a guardare. L’esodo finale dei sopravvissuti attraverso il confine della zona verde fino al museo, nel cuore di una Beirut violentata, sembra più una sequenza cinematografica che il finale di un romanzo:
Sulla linea che divideva le due città, dove un edificio chiamato museo se ne stava accovacciato, Aisha stava in piedi all’ingresso, come un piccolo insetto, in attesa che arrivasse la famiglia, o ciò che ne rimaneva. La costruzione si estendeva, sprezzante e imponente, con le sue colonne romane o forse fenice, stando a quanto Aisha aveva studiato a scuola. Fissò la dura pietra e si disse: perché ci fanno questo? Se è perché bramano le glorie del tempo dei Romani, noi siamo i cristiani da sacrificare coi leoni nelle arene? E se vogliono tornare all’epoca dei Fenici, perché assalirci in questo modo? Sono passate migliaia di anni, perché ci annientano e ci uccidono?
Colei che vive, Aisha, apre e chiude un romanzo di struggente bellezza, che si estende nell’arco degli otto mesi dell’assedio di Tel al-Zaatar, e lì, ai piedi del museo guarda in faccia il futuro e assume su di sé tutte le responsabilità. Perché lei, Aisha, il futuro lo porta in grembo.


[…] [7] https://www.anbamed.it/2023/05/26/finestra-sulle-rive-arabe-la-collina-che-non-profuma-piu-di-timo/ […]