Il New York Times ha dato istruzioni ai giornalisti che si occupano della guerra di Israele nella Striscia di Gaza di limitare l’uso dei termini “genocidio” e “pulizia etnica” e di “evitare” di usare l’espressione “territorio occupato” quando descrive la terra palestinese, secondo un rapporto copia di una nota interna ottenuta da The Intercept.
Il promemoria dà inoltre istruzioni ai giornalisti di non usare la parola Palestina “tranne in casi molto rari” e di evitare il termine “campi profughi” per descrivere aree di Gaza storicamente abitate da palestinesi sfollati espulsi da altre parti della Palestina. Le aree sono riconosciute dalle Nazioni Unite come campi profughi e ospitano centinaia di migliaia di rifugiati registrati.
Il promemoria – scritto dall’editore degli standard del Times, Susan Wessling, dall’editore internazionale Philip Pan e dai loro delegati – “offre indicazioni su alcuni termini e altre questioni con cui ci siamo confrontati dall’inizio del conflitto in ottobre”.
Ecco cosa scrive il maestro Eric Salerno su questo caso. (Articolo ripreso da Africa-express QUI
“The Intercept” denuncia il decalogo del “New York Times” da usare per Israele e Gaza
Secondo l’autorevole sito indipendente, i giornalisti del quotidiano non possono parlare di “genocidio” e “pulizia etnica” né di “territorio occupato”
Da La Voce di New York
Eric Salerno
19 aprile 2024
Sempre più spesso, nel bene e nel male, i fatti di oggi riportano alla memoria episodi in qualche modo simili del passato. “All the News That’s Fit to Print”: sette parole in inglese, probabilmente le più famose del giornalismo, le vedevo tutti i giorni sulla prima pagina, in alto accanto alla testata, sulla copia del New York Times che mio padre portava a casa nel Bronx quando tornava dopo un’intensa giornata di lavoro a Manhattan.
Dal febbraio 1897, il motto non si è più mosso dalla prima pagina del quotidiano e da anni, come scrisse qualche anno fa un docente universitario americano, “è ammirato come una dichiarazione di intenti senza tempo, è stato interpretato come un ‘grido di guerra’ per l’onestà del giornalismo e preso in giro come pretenzioso, esagerato e incredibilmente vago.”

Giubbotto Press a Gaza
Credit: ANSA
Crescendo e imboccando il mestiere del giornalista cercavo di adeguare il mio comportamento alle interpretazioni positive di quelle sette parole anche mentre vedevo sempre di più che spesso, troppo spesso, le nostre interpretazioni dei fatti non corrispondevano necessariamente alla realtà.
E, soprattutto, il giornale newyorkese, come la maggioranza dei quotidiani del mondo, non sempre si interessava dei fatti che valeva la pena raccontare e non sempre quelli che raccontava valeva la pena leggere.
Il bambino-ragazzo innamorato di un mestiere era cresciuto. Ed erano cresciuti anche i termini, gli aggettivi, le parole usate per descrivere fatti e persone. Come quando – piccola cosa forse – il mio primo direttore mi criticò quando scrisse la storia di un “vecchio ammazzato e trovato per strada”. “Non si dice vecchio – disse – la parola giusta e che non offende nessuno è: anziano”.
Molti giornali hanno a disposizione dei redattori un dizionario-decalogo con le parole da usare e quelle bandite perché scorrette o disturbanti. L’altro giorno, un noto gruppo di lavoro statunitense formato da giornalisti indipendenti, The Intercept, ha denunciato una specie di decalogo interno del NY Times che impone ai suoi dipendenti di usare alcune parole e altre no, di raccontare alcune verità e altre no.
Il motto di The Intercept è forse presuntuoso ma chiaro: “Indaghiamo su individui e istituzioni potenti per esporre la corruzione e l’ingiustizia. Vediamo il giornalismo come uno strumento di azione civica. Siamo qui per cambiare il mondo, non solo per descriverlo”.

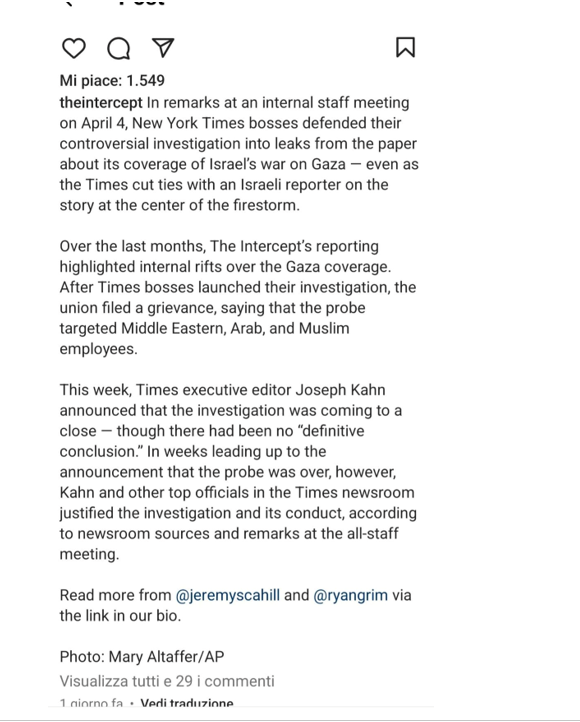
Vale la pena leggere alcuni passaggi della loro denuncia: “Il New York Times ha incaricato i giornalisti che coprono la guerra di Israele sulla Striscia di Gaza di limitare l’uso dei termini genocidio e pulizia etnica e di evitare di usare la frase territorio occupato quando si descrive la terra palestinese. […] Il memorandum istruisce anche i giornalisti a non usare la parola Palestina tranne in casi molto rari e a evitare la formula campi profughi per descrivere le aree di Gaza storicamente abitate da palestinesi sfollati espulsi da altre parti della Palestina durante le precedenti guerre israelo-arabe. […]
“Mentre il documento è presentato come uno schema per mantenere principi giornalistici obiettivi nel riferire sulla guerra di Gaza, diversi membri dello staff del Times hanno detto a The Intercept che alcuni dei suoi contenuti mostrano prove della deferenza del giornale per le narrazioni israeliane. […] Distribuita per la prima volta ai giornalisti del Times a novembre, la guida – che ha raccolto e ampliato le direttive del passato sul conflitto israelo-palestinese – è stata regolarmente aggiornata nei mesi successivi […]”.
“Fornire indicazioni come questa per garantire accuratezza, coerenza e sfumature nel modo in cui copriamo le notizie è una pratica standard”, ha detto Charlie Stadtlander, un portavoce del Times. “Vogliamo garantire che le nostre scelte linguistiche siano sensibili, attuali e chiare per il nostro pubblico”.
A gennaio, The Intercept ha pubblicato un’analisi della copertura del New York Times, del Washington Post e del Los Angeles Times della guerra dal 7 ottobre al 24 novembre, prima che fosse pubblicata la nuova guida. “L’analisi ha mostrato che i giornali riservavano termini come massacro e orribile quasi esclusivamente per i civili israeliani uccisi dai palestinesi, non per i civili palestinesi uccisi negli attacchi israeliani. La parola macello – ricorda Intercept – era stato usato 22 volte per raccontare quello che era stato compiuto da Hamas, ma solo una volta per descrivere i 15 mila palestinesi uccisi fino ad allora negli attacchi israeliani”.
“Nei casi di descrizione del territorio occupato e dello status dei rifugiati a Gaza – insiste Intercept, – le linee guida del Times sono in contrasto con le norme stabilite dalle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario. Sul termine Palestina – un nome ampiamente usato sia per il territorio che per lo Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite – la nota del Times contiene istruzioni: “Non usare in date, testo o titoli, tranne in casi molto rari come quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha elevato la Palestina a uno Stato osservatore non membro o riferimenti alla Palestina storica”.
Linee guide chiaramente in linea con la politica e, direi, l’ideologia di Benjamin Netanyahu e della maggioranza dei ministri che fanno parte della coalizione di governo.
Eric Salerno
